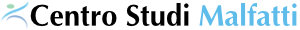Perchè dire NO alla riforma costituzionale che divide l’Italia
(Intervento di Tabacci alla Camera del 14 settembre 2004)
BRUNO TABACCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, le riforme costituzionali rischiano di divenire il principale terreno di scontro politico tra maggioranza e opposizione. La Costituzione repubblicana, come è noto, rappresenta l’eccellente risultato di un confronto estremamente positivo e fecondo tra tre filoni culturali e politici sicuramente eterogenei, ma che hanno saputo dare vita ad un sistema coerente, in grado di garantire all’Italia oltre mezzo secolo di pace, di sviluppo e di prosperità.
Oggi che le distanze, se non altro sotto il profilo ideologico, appaiono infinitamente più ridotte, il prevalere di un clima di contrapposizione e di scontro appare del tutto irragionevole. Ad alimentare la contesa, e ciò è il fatto più grave, è che all’interesse costituzionale del paese sembrano concorrere interessi politici contingenti, sovente di basso profilo. In questo modo, il dibattito sulle riforme rischia di risultare di livello estremamente scadente e di fare arrossire di vergogna chi ricorda la passione civile, lo spessore del confronto che animò l’Assemblea costituente. Un errore grave fu l’approvazione della riforma del Titolo V, nella scorsa legislatura. Si trattò di una grave rottura rispetto ai principi che avevano prevalso nell’Assemblea costituente.
È grave che il centrosinistra continui a minimizzare tale responsabilità! Per quanto ci riguarda, non dovremmo ripetere l’errore commesso da chi era maggioranza allora, promuovendo una riforma che possa apparire di parte e che, soprattutto, rischi di far prevalere posizioni rigide, non sufficientemente meditate, e di non affrontare compiutamente alcuni nodi attraverso scelte chiare, pagando così un pesante tributo alla volontà di approvare comunque una riforma per segnare un punto politico a proprio favore. Non si deve ripetere, su scala tra l’altro più ampia, il grave errore compiuto nella scorsa legislatura.
Una simile scelta avrebbe riflessi estremamente negativi per la credibilità e la tenuta del sistema politico istituzionale. Quando si mette mano alla Costituzione, non vi sono avversari politici da sconfiggere, e le riforme, quelle vere e durature, nascono sempre dal vissuto collettivo di un paese, interpretato dal complesso delle forze politiche e culturali. Il confronto ed il dialogo sono, quindi, il presupposto indispensabile di riforme costituzionali valide ed efficaci. Nel 1948 i costituenti seppero
definire soluzioni di compromesso alte e, nel contempo, complesse e difficili. Oggi, le posizioni di partenza sono oggettivamente assai più ravvicinate e raggiungere un’intesa di fondo su punti fondamentali è un obiettivo sicuramente alla portata delle forze politiche, oltre che conforme agli interessi generali del paese. Occorre, a mio avviso, a questo punto, operare un distinguo: sul federalismo e il Titolo V della Costituzione vi è la necessità di correggere, da un lato, e completare, dall’altro, un lavoro già avviato nella scorsa legislatura.
Tra l’altro, vi è una sentenza della Corte costituzionale del luglio 2003 che ci induce a fare ciò. Al riguardo mi sembra che il testo prodotto dal Senato possa e debba essere approfondito sotto taluni aspetti e non vi è dubbio che vi sia la necessità e l’urgenza di agire nei due sensi che ho appena indicato. Aggiungerei che, sul punto, il centrodestra ha tutto il diritto di intervenire e il centrosinistra, d’altro canto, avrebbe tutto l’interesse a prestare la sua piena collaborazione. Assai meno maturi mi sembrano gli altri due capitoli della riforma che ci giunge dal Senato, sia il premierato che il Senato federale. Ciò malgrado le aperture, che ho segnato con grande compiacimento, che ieri ha portato in quest’aula il ministro Calderoli, in termini di stile e direi anche in termini di atteggiamento complessivo.
Anche in questo caso non si tratta di scelte di fondo che possono essere ampiamente condivisibili e condivise, ma della struttura complessiva della riforma che risente di troppe disparate sollecitazioni. È il frutto, da un lato, di una contaminazione di una pluralità di modelli europei e, dall’altro, di input politici diversi, scarsamente filtrati e organizzati sotto il profilo costituzionale. Non è, ad esempio, positivo il fatto che si sia lasciato intendere che ad un pezzo della coalizione andava il meccanismo A, ad un altro pezzo il meccanismo B e ad un terzo pezzo il meccanismo C. Non è così, io credo, che si può procedere.
Su questa materia occorre, a mio avviso, svolgere una riflessione più approfondita, interrogandosi sull’efficacia e sulla coerenza di alcune scelte. Soprattutto su questa materia mi sembra occorra un forte impegno per definire un’architettura costituzionale equilibrata e convincente, in grado di conquistare un consenso parlamentare ampio. Cercherò ora di illustrare meglio le due opzioni che, a mio giudizio, abbiamo di fronte. Per quanto riguarda il federalismo, che io più volentieri chiamerei regionalismo (ma non è un fatto nominalistico), questo appare come il terreno più facile da arare, rispetto al quale non sarebbe affatto scandaloso limitare per il momento l’intervento riformatore.
Mi sembra che le cose da fare su questo punto siano fondamentalmente tre. In primo luogo, occorrerebbe fare chiarezza in merito agli elementi costitutivi della Repubblica come definiti nel testo del primo comma dell’articolo 114. A tal proposito, è inutile che il centrosinistra si ritragga, perché quel testo l’ha scritto e l’ha voluto così. Non so, poi, chi volesse inseguire, ma è un fatto che così è scritto. Tale disposizione identifica nello Stato un elemento costitutivo della Repubblica al pari degli altri enti territoriali. È una scelta che non ha eguali nel costituzionalismo contemporaneo, a cominciare proprio dagli Stati federali. Il federalismo, infatti, è un tratto costitutivo dello Stato che presenta una struttura articolata e riconosce dignità costituzionale alle minori unità territoriali.
Lo Stato nel caso italiano è anche una Repubblica democratica, ad indicare la forma di Governo prescelta che – come è noto – non può essere oggetto, in questo suo nucleo essenziale, di revisione costituzionale. Se vogliamo, come fanno altre Costituzioni, attribuiamo espressamente allo Stato italiano la qualifica di federale, ma dobbiamo convincerci della necessità di correggere un’acrobazia linguistica senza precedenti. La Repubblica, quindi, si identifica sostanzialmente con lo Stato. Se smarrisce il suo collegamento con lo Stato, la Repubblica diviene un concetto privo di contenuti. Quali sono i suoi organi, quali i suoi poteri, in che forma manifesta la sua volontà? Vi è di più: l’articolo 5 della Costituzione prevede tuttora che la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.
Qui chiaramente la Repubblica si identifica con lo Stato e non è un mero contenitore di enti territoriali, come sembra fare intendere l’articolo 114 nel nuovo testo. Potremmo dire che, mentre per l’articolo 5 il federalismo – o il regionalismo che dir si voglia – è un attributo positivo dello Stato e ne determina il modo di essere e di operare, per l’articolo 114 il federalismo sembra divenuto quasi un’imposizione, un limite, un vincolo esterno al quale lo Stato si deve sottomettere e che, peraltro, non si sa bene chi dovrà far valere.
Per l’articolo 5 lo Stato, proprio perché federale, può essere un garante credibile dell’unità e dell’indivisibilità della Repubblica; per l’articolo 114 il garante di tali valori non sembra più esistere e tutto è affidato alla libera dialettica tra i poteri territoriali e autonomi, con le conseguenze che sono all’attenzione della Corte costituzionale e che rendono assai problematico qualsiasi percorso riformatore.
Negli Stati federali il garante dell’unità giuridica ed economica della nazione e, ancora prima, del valore dell’uguaglianza di tutti i cittadini è lo Stato, al quale la Costituzione riconosce, a tal fine, specifiche prerogative. La riforma del 2001 ha attribuito alle regioni numerose competenze sulla base di valutazioni frettolose, in parte determinate dal clima politico del momento storico, che in alcuni casi hanno portato a concedere troppo, mentre in altri hanno portato a concedere troppo poco. Vengo al secondo intervento fondamentale in materia di federalismo: dalla premessa discende che la devoluzione, ossia l’attribuzione di competenze ulteriori alle regioni, può sicuramente avvenire e non è di per sé un fatto negativo. D’altro canto, riguardo ad alcune materie, tutti, a partire dalle stesse regioni, ci rendiamo conto di come si sia proceduto in modo avventato ed incauto.
Mi riferisco ad esempio alla materia dell’energia, a quella delle grandi reti e alle professioni, ambiti per i quali allo Stato deve essere riconosciuta la competenza esclusiva, salvo, come è ovvio, il rispetto di alcune prerogative regionali, ad esempio in materia di gestione del territorio. Vorrei dire che un paese come il nostro, che vuole adottare grandi riforme, ma che non riesce neanche a localizzare gli impianti di termovalorizzazione, non va molto lontano! Questo comporta che, quando si parla di sussidiarietà, si debba affiancare a tale concetto il principio della responsabilità (non vi è
soltanto Acerra, ma anche Viterbo); mandiamo in Germania i rifiuti, così pagheremo due volte: una prima per mandarli, una seconda per importare energia!
C’è infine una disposizione che considero necessaria al fine di allentare la tensione e dirimere la conflittualità che caratterizza in questo momento la discussione in ordine alle competenze regionali. È indispensabile introdurre una clausola di flessibilità che consenta in ogni caso allo Stato di legiferare quando sono in gioco valori costituzionali unitari e fondamentali: mi riferisco all’uguaglianza dei cittadini, ai diritti fondamentali e all’unità giuridica ed economica del paese.
Legiferare, si badi bene, non contro le regioni, ma, nella stragrande maggioranza dei casi, per rafforzare e completare le politiche regionali. Ciò comporta un’assunzione di responsabilità che porta a considerare il potere regionale non come una sorta di opposizione rispetto al potere centrale; questa in qualche modo è una condizione nella quale in parte il centrosinistra ed in parte il centrodestra si sono trovati. È tuttavia una condizione da evitare perché soltanto attraverso la collaborazione istituzionale è possibile compiere passi in avanti.
Nell’ottica di un federalismo competitivo una simile clausola non viene compresa, ma in una visione cooperativa e collaborativa del federalismo ne diviene, al contrario, una vera e propria architrave. L’esperienza ci ha insegnato come l’applicazione del principio di sussidiarietà richieda grande flessibilità e grande elasticità: non è possibile “tagliare” le materie con il coltello e regioni e Stato non possono esimersi dal coordinare le rispettive attività. Questo, a mio avviso, richiederebbe in sintesi una corretta riforma federalista ed è un esito al quale, con un po’ di buona volontà, si può arrivare rapidamente nel corso di questa sessione di lavori. In ordine al premierato, il discorso è assai più complesso: attualmente, il modello difetta soprattutto di chiarezza ed appare il frutto della contaminazione di esperienze diverse, senza un vero filo conduttore. La forma di governo è stata oggetto di interventi – nel tentativo di rafforzare la stabilità dell’esecutivo – che, attraverso la valorizzazione della figura del premier, hanno individuato meccanismi di razionalizzazione ispirati a diverse esperienze europee, nonché hanno introdotto un’assoluta novità.
Mi riferisco all’idea che occorra vietare espressamente, con un intervento di livello costituzionale, un cambiamento di maggioranza in corso di legislatura, il cosiddetto “ribaltone”. In nessun paese europeo esistono garanzie antiribaltone, anche se in tutti i maggiori paesi europei un cambio di maggioranza in corso, ovvero di premiership, è visto con evidente sfavore e rappresenta comunque ipotesi eccezionale che presuppone un ricorso ravvicinato al giudizio dell’elettorato. Non è pertanto il fine, quanto i mezzi utilizzati, a risultare anomali e tali da alterare, anche in chiave europea, gli ordinari rapporti fra il premier, la maggioranza e la Camera politica, a tutto vantaggio del primo, ma con un’utilità assai dubbia per l’efficienza e la stabilità complessiva del sistema. Il rischio è quello di perdere di vista il delicato equilibrio di poteri e di responsabilità che caratterizza la generalità delle forme di governo parlamentari o neoparlamentari.
Alla base della riforma vi sarebbe il rispetto della volontà elettorale, ma di tale volontà viene esaltato un aspetto, trascurandosi gli altri. L’elettore, ai sensi del vigente sistema elettorale, la cui filosofia si vorrebbe sostanzialmente confermare, anche se rafforzandone gli effetti, sceglie un singolo candidato al Parlamento, al quale affida un mandato politico pieno e non condizionato o limitato (senza vincolo di mandato, per l’appunto), una maggioranza politica – allo stato, o almeno nell’immediato futuro, immagino si tratterà di una maggioranza pluripartitica – dando tra l’altro il proprio voto ad una singola e distinta forza politica all’interno della coalizione; sceglie infine un programma di governo elaborato dall’intera coalizione e un capo del Governo, ovvero dell’opposizione, in caso di sconfitta della coalizione prescelta.
Il voto sottende, quindi, una scelta plurima che deve essere integralmente rispettata in corso di legislatura. In particolare, l’impegno di attuare il programma è assunto nei confronti dell’elettorato da tutte le forze della coalizione e da tutti i singoli esponenti che la compongono e non si risolve in un rapporto esclusivo e diretto tra premier e corpo elettorale (a tale proposito, credo che entrambe le coalizioni soffrano, in questo momento, della difficoltà di individuare politicamente il punto di equilibrio). Quest’ultima condizione – è bene ricordarlo – si realizza solo nei regimi presidenziali, dove il Governo è potere del tutto distinto ed autonomo dal Parlamento, e viceversa. Il Presidente ha i suoi poteri, ma il Parlamento ne ha di altrettanto penetranti e può condizionare fortemente l’azione dell’esecutivo.
Come è noto, il Presidente americano ha un programma e viene eletto, ma quante cose il Presidente Clinton o l’attuale Presidente Bush non riescono a portare avanti quando trovano l’ostacolo insormontabile del Parlamento americano! Se rimaniamo nella logica dei regimi parlamentari, il Parlamento non può essere considerato semplicemente un terzo incomodo la cui volontà deve sistematicamente cedere il passo a quella del premier, ma un attore vivo della dialettica istituzionale in grado di condizionare l’azione del Governo. In materia occorrerebbe, nel confermare gli obiettivi della riforma, realizzare un maggiore equilibrio, attenuando talune forzature che talvolta rischiano di risultare controproducenti per lo stesso Capo del Governo. In primo luogo, è giusto sancire la competenza del primo ministro a nominare e revocare i ministri, ma perché non prevedere che l’atto venga formalmente adottato dal Presidente della Repubblica al fine di rafforzare
la natura istituzionale di tali adempimenti e di attribuire al premier un maggior margine di manovra? Così avviene in Germania, in Austria, in Spagna, per fare alcuni esempi a noi più vicini, senza che ciò determini alcun inconveniente.
Si prevede, inoltre, che il primo ministro determini la politica generale del Governo (articolo 29) nel presupposto, evidentemente, che il compito di dirigerla che la Costituzione attualmente gli assegna risulti inadeguato. Diversamente, non vi sarebbe ragione di mutare anche terminologicamente tale elemento. Dunque, mentre il programma di Governo sottoposto al corpo elettorale si configura come espressione di un accordo di coalizione realizzato con il concorso di tutte le componenti della maggioranza, la politica generale del Governo, che deve tradurlo in pratica, diverrebbe il prodotto di una solitaria decisione del premier.
È la logica del bi leaderismo a cui spesso ho fatto cenno criticando gli eccessi della cosiddetta seconda Repubblica. Inoltre, il Governo sembra in tal modo perdere il carattere di organo politico venendo ridotto ad organo esecutivo chiamato ad attuare una linea politica determinata esclusivamente dal premier. È proprio necessaria una simile sottolineatura delle prerogative del premier? È proprio necessario lasciarsi affascinare da una formulazione introdotta nella Costituzione tedesca e che appare, peraltro, tutt’altro che determinante ai fini dell’assetto di quella forma di Governo?
Come si concilia una simile scelta con il principio di collegialità, che rappresenta un elemento costitutivo dei governi di coalizione e, per immergerci nell’attualità, con la giusta rivendicazione di collegialità che caratterizza la discussione interna allo stesso Governo in carica? È uno dei termini che un giorno sì e l’altro pure viene ricordato. La disposizione che più accentua il primato del premier nei confronti della sua maggioranza e della Camera è rappresentata dall’articolo 23, che sostituisce l’articolo 88 della Costituzione. L’incongruenza non è rappresentata dalla previsione relativa allo scioglimento (l’attribuzione di un tale potere al premier può rientrare nella fisiologia delle forme di Governo neoparlamentari, anche se dovremmo guardare in maniera molto critica all’esperienza dei consigli regionali ed a quella fatta dai cosiddetti governatori), ma dalla pesantezza e dalla rigidità della procedura con cui la Camera può opporsi allo scioglimento. Prevedere, infatti, che la mozione in cui si indica il nome di un nuovo primo ministro debba essere presentata da deputati della maggioranza in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera rappresenta una scelta censurabile sotto più aspetti. Nega, innanzitutto, implicitamente in radice la possibilità di governi di minoranza o, comunque, rende irragionevolmente inapplicabile a tali governi la procedura di sostituzione del primo ministro. Attribuisce una valenza diversa alla volontà, e perfino al voto, dei deputati della maggioranza e dell’opposizione rappresentando un precedente assoluto nel diritto parlamentare.
Sottrae, di fatto, il primo ministro al controllo della sua stessa maggioranza, essendo infatti sufficiente che il premier controlli un manipolo di deputati (circa venticinque-trenta), per definirlo di fatto inamovibile, salvo l’ipotesi di contestuale scioglimento della Camera. Quest’ultimo è un aspetto importante, perché il potere di scioglimento riconosciuto al premier può rappresentare un importante deterrente volto a garantire l’unità della maggioranza. Ciò tuttavia, nei paesi nei quali è previsto (a cominciare dalla Gran Bretagna), non pone il premier al riparo dal giudizio della sua maggioranza, perché quando nel partito della maggioranza prevale un orientamento favorevole alla sostituzione del premier, questa diviene legittima e possibile (è accaduto anche alla signora Thatcher). Tale scelta è compiuta nell’interesse della stessa maggioranza, che si persuade della necessità di cambiare il proprio leader, per non andare incontro ad un insuccesso elettorale.
Il premier in questi casi normalmente si adegua – se è una persona che ha acume politico – e cede il passo, ma soprattutto, in considerazione di una simile eventualità, è indotto al confronto costante con la maggioranza che esprime. Tutta questa vicenda dell’uomo solo al comando (che, intendiamoci, riguarda tutti)! L’idea che il premier debba solo poter usare la frusta per domare una maggioranza riottosa ed essere in grado di soffocarne ogni velleità politico programmatica rappresenta una distorsione del corretto funzionamento dei regimi parlamentari e non corrisponde nemmeno alla realtà dei regimi presidenziali, quasi che nei paesi a democrazia parlamentare la governabilità poggi non sulla capacità di persuadere, bensì sulla coercizione delle volontà.
Blindare il premier ad ogni costo, prevedendo per la sua sostituzione una procedura del tutto anomala e assai difficile da esperire, rappresenterebbe una scelta senza precedenti nelle democrazie parlamentari, in grado di determinare situazioni confuse e incerte e, in ultima analisi, tutt’altro che a favore della governabilità. La soluzione più semplice sta nel prevedere che la mozione in questione venga presentata da un determinato quorum di deputati (un decimo, come prevede la Costituzione spagnola, o un terzo, se si vuole rendere più onerosa la procedura), senza distinzione di schieramenti politici. Le garanzie nei confronti del trasformismo parlamentare vanno ricercate nelle convenzioni costituzionali, nella formazione di un’etica pubblica e, in ultima istanza,
nel giudizio degli elettori. Pensare di imporle per via costituzionale rappresenterebbe un tentativo vano e controproducente per quanto riguarda l’equilibrio e la funzionalità della forma di Governo.
Tra l’altro, con riferimento alla cosiddetta “transumanza parlamentare”, per citare un termine caro al presidente Biondi, devo ricordare che nell’arco di cinquant’anni sono stati solo undici i parlamentari che hanno cambiato casacca. Le centinaia di parlamentari che hanno imparato a cambiare casacca sono un costume della seconda Repubblica, non della prima! Altra scelta da approfondire appare quella relativa all’introduzione del cosiddetto voto bloccato, sul quale si innesta anche la questione di fiducia (articolo 28).
Si assemblano, quindi, introducendo una possibilità di deroga sostanzialmente illimitata alle ordinarie procedure parlamentari, due istituti diversi. Non solo il premier può chiedere alla Camera dei deputati di esaminare prioritariamente, esprimendo un voto conforme, le sue proposte, ma tale richiesta equivale alla posizione di un voto di fiducia. Pertanto, senza alcuna garanzia e limitazione, il dibattito parlamentare può venire drasticamente circoscritto e la stessa maggioranza sarebbe sollecitata ad un’adesione acritica per scongiurare il proprio scioglimento.
Senza bisogno di ricorrere all’artificio dei maxiemendamenti, il Governo disporrebbe di una formidabile scorciatoia per far passare, al riparo dal confronto parlamentare, le proprie proposte legislative. In luogo di tale previsione, appare decisamente preferibile disciplinare separatamente i due istituti: la posizione della questione di fiducia, che deve configurarsi come un’ipotesi eccezionale (e non la via ordinaria per l’attuazione del programma di Governo), e la previsione di effettive corsie preferenziali per i disegni di legge del Governo, con possibilità di voto bloccato, che non escludano tuttavia un minimo di confronto parlamentare e l’esercizio, sia pure circoscritto, del diritto di emendamento. Anche in questo caso, ridurre il Governo e la figura del premier appare come un’inutile forzatura, priva di corrispondenza con gli effettivi equilibri politici interni ai Governi ed in particolare ai Governi di coalizione.
La composizione e le prerogative del Senato federale, nonché le modifiche alla disciplina delle competenze legislative regionali si prestano a rilievi che attengono all’impostazione complessiva della riforma e all’equilibrio che viene in tal modo a realizzarsi tra istanze statali e istanze regionali. Il Senato federale, com’è noto, è stato fatto oggetto di critiche, tanto penetranti quanto ampiamente condivise, e ciò ha indotto la Commissione affari costituzionali a modificarne in maniera non trascurabile i poteri. Non è stata tuttavia corretta la composizione dell’organo, che ne rende per molti aspetti incerta la natura. In particolare, appare dubbio che il Senato possa ritenersi effettivamente rappresentativo delle realtà regionali, poiché si è rinunciato sia a renderlo espressione dei consigli o delle giunte regionali sia a renderlo comunque rappresentativo delle regioni su di un piano di tendenziale parità.
La discussione al riguardo sarebbe troppo lunga. È noto anche dalle audizioni che si sono tenute che il problema è stato sollevato in tutta evidenza. Un’anomalia che andrebbe sicuramente eliminata è la prevalenza del Senato nel procedimento legislativo; circostanza che non si verifica in alcun ordinamento federale e lo dico non come deputato – ci mancherebbe altro -, ma come legislatore, mi auguro responsabile. Vi è un’altra esigenza da non trascurare, quella di non complicare e diversificare eccessivamente i procedimenti legislativi.
La questione rileva, in particolare, nella determinazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente. La Commissione affari costituzionali ha individuato una soluzione di mediazione che sembra, tuttavia, presentare ancora un’eccessiva farraginosità. Costruisce un elemento con tre attori, nel quale il Governo svolge, in sostanza, un ruolo autonomo e rischia di generare contrapposizioni, piuttosto che favorire la conciliazione delle posizioni.
Su tali questioni mi si dice che è stato compiuto qualche ulteriore passo in avanti, ma non ne sono a conoscenza e mi auguro che i passi in avanti siano in coerenza con le indicazioni auspicate. A questo punto la soluzione preferibile sembra quella di ridurre a due i procedimenti alternativi: uno a prevalenza Camera ed uno paritario, salvo affidare, nella seconda ipotesi, in caso di mancato accordo, la decisione definitiva alla Camera, con facoltà, come accennato, per il Senato di opporsi a maggioranza qualificata, salvo che alla Camera non sia stata già raggiunta una simile maggioranza.
Desta, inoltre, rilevante contrarietà la scelta di affidare al procedimento legislativo paritario, che, allo stato, assegna al Senato una sorta di diritto di veto, la tutela della concorrenza. Secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 14 del 2004 ed altre pronunce conformi, la regolazione della concorrenza costituisce una delle leve della politica economica statale comprensiva di tutti gli strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell’intero paese. Il Senato viene in tal modo posto nella condizione di vincolare l’intera politica economica dello Stato, senza essere la Camera di fiducia politica del Governo. Quindi, in qualche modo, può diventare il punto di tenuta dell’attuazione della politica economica del Governo.
Credo che la materia debba essere senz’altro assegnata al procedimento a prevalenza della Camera che esprime la fiducia al Governo. L’ultima rilevante questione sulla quale riflettere riguarda la valorizzazione dell’opposizione. L’introduzione di elementi di uno statuto dell’opposizione (bisogna sempre guardare in avanti nella vita!) avrebbe la funzione di riequilibrare un sistema caratterizzato da un complesso di meccanismi di razionalizzazione dell’organo di Governo e da un debolissimo riconoscimento della funzione oppositoria.
Non si comprende, infatti, perché, mentre dal lato del Governo non si riscontrano esitazioni nel rafforzarne il premier, fino a configurarlo, come ho tentato di dimostrare evidenziando un disaccordo, nei termini di un organo monocratico, ricorrendo ad un mix di suggestioni tratte dal diritto comparato (premier all’inglese, scioglimento di tipo spagnolo, voto bloccato alla francese), nei confronti del capo dell’opposizione della coalizione che esso rappresenta non si sia operato con una logica analoga, in modo da configurarlo nei termini di un interlocutore autorevole e qualificato del premier, in grado di impegnarlo nella dialettica parlamentare e di assicurare un alto livello del confronto politico ed istituzionale.
Credo che un candidato alternativo che vuole allenarsi a diventare il premier di un paese è bene che lo faccia nel crogiolo, nella durezza del dibattito parlamentare e non aspettando chi non c’è. In tal modo, verrebbe valorizzato il ruolo di tutte le forze di opposizione, evitando il rischio della marginalizzazione del confronto parlamentare. Sul piano delle garanzie si dovrebbe assegnare alla Corte costituzionale l’ultima parola in materia di verifica dei poteri e di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, al fine anche di sfatare il mito dell’insindacabilità degli interna corporis che danno poi vita ad alcune situazioni davvero un po’ aberranti, come è accaduto anche in questa legislatura. Non è che compete a noi decidere se le schede siano dieci od otto (lo si potrebbe fare in prima istanza); altrimenti, nel nuovo sistema il problema rischia di risolversi nell’esclusiva tutela delle ragioni della maggioranza, consentendo all’opposizione di impugnare le leggi dinanzi alla Consulta per vizi in procedendo.
Tra l’altro, in questo caso, si valorizzerebbe ancor di più il ruolo del Presidente della Camera, la cui funzione verrebbe rafforzata in una posizione di garante di un’imparziale applicazione del regolamento, venendo sottratto, in tale ambito, al rischio di subire condizionamenti eccessivi da parte della sua maggioranza. Credo – ed ho concluso – che, per garantire la trasparenza dell’azione di Governo e l’esercizio della facoltà di criticane l’azione e di rappresentare le possibili alternative, consentendo la formazione di un’opinione pubblica politicamente consapevole, appare essenziale valorizzare il ruolo del Parlamento, quale sede privilegiata del dibattito politico.
Se vogliamo che vi sia un controllo effettivo su chi governa e se crediamo nella dottrina sui limiti del potere da chiunque interpretato, occorre non relegare le Camere ad un ruolo marginale e prevalentemente simbolico. L’opposizione deve essere visibile, dotata di risorse e in grado di provocare il confronto sui temi politici fondamentali dinanzi all’opinione pubblica. Da tale circostanza dipenderà in misura non trascurabile la qualità della nostra democrazia. In conclusione, in questa situazione si possono seguire due strade e forse in questa fase bisognerebbe essere in grado di progettare e sostanziare con proposte concrete entrambi i percorsi. Il primo percorso è quello di seguire la normale strada del procedimento bicamerale.
Il Senato ha fatto la sua parte svolgendo i temi fondamentali; la Camera svolge la sua introducendo tutti i possibili correttivi maturi a questo punto, sottoponendoli nuovamente al Senato, che li assesterà e li ritrasmetterà alla Camera. Il dibattito, se non sarà costretto all’interno di artificiose strettoie di tempi ed impensabili blindature con assurde imposizioni ad una Camera o all’altra, potrà nel frattempo maturare ed estendersi al paese, giungendo a soluzioni equilibrate e condivise.
Infatti, se in questa vicenda vi è un convitato di pietra, è che l’opinione pubblica non ha assolutamente partecipato a questa fase di dibattito, alla quale attribuiamo grande importanza. Il secondo percorso è quello di anticipare la discussione e l’approvazione della modifica della riforma del Titolo V, cominciando dunque a discutere gli emendamenti dall’articolo 114 all’articolo 117 e di prospettare la possibilità di una norma transitoria di rango costituzionale che formuli un principio finalizzato – che obblighi a completare la riforma entro un tempo determinato – e definisca nel contempo una procedura speciale per l’elaborazione della riforma al Senato e con essa della forma di governo nazionale.
Tale procedura speciale dovrebbe puntare sull’elezione di un’assemblea costituente e sulla convocazione di una convenzione del tipo di quella europea con poteri redigenti. Questa è l’interpretazione politica che fornisco al dibattito svoltosi finora, ovviamente nei limiti in cui ciò è consentito ad un deputato. Infatti, tutti i discorsi svolti in queste settimane e in questi mesi, dai saggi di Lorenzago in poi, non ci hanno visti protagonisti.